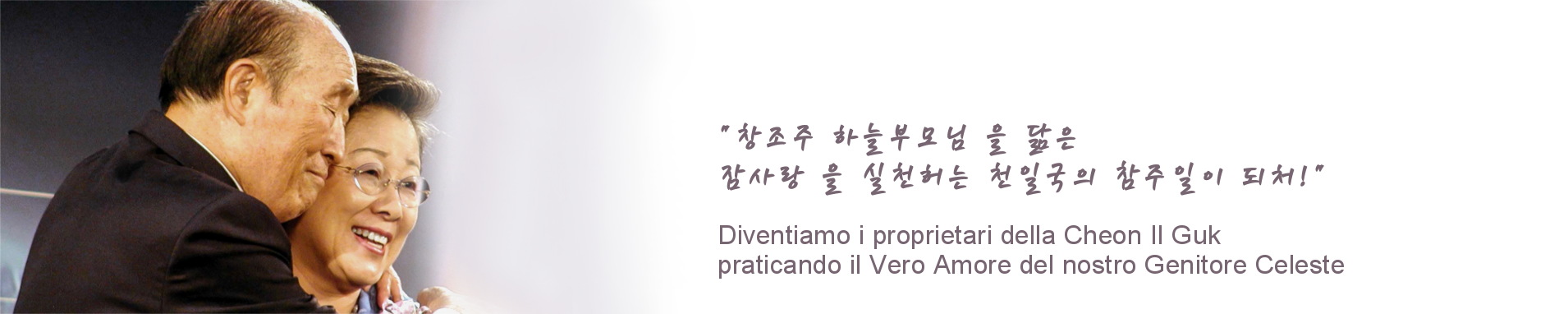La chiave per svelare un grande segreto – il Centenario di Sun Myung Moon
LA CHIAVE PER SVELARE UN GRANDE SEGRETO
Durante i suoi studi in Giappone, Sun Myung Moon ha condiviso la sua vita assieme agli operai e alle persone più bisognose. La sofferenza è parte della nostra esperienza umana. Solo comprendendo la sofferenza e le persone sofferenti, Sun Myung Moon ha potuto capire più profondamente il cuore di Dio e la Sua volontà.
Proprio come avevo fatto a Seul, mi posi l’obiettivo di visitare ogni angolo di Tokyo. Quando
i miei amici andavano in posti come Nikko ad ammirare il paesaggio, io preferivo restare in città e camminare per i quartieri di Tokyo. Scoprii che era una città molto bella in apparenza, ma in realtà piena di gente povera. Anche lì donai ai poveri tutti i soldi che avevo ricevuto da casa.
A quel tempo, anche in Giappone erano tutti affamati. Tra gli studenti Coreani ce n’erano molti in difficoltà economiche. Ogni mese, quando ricevevo i miei buoni pasto, li distribuivo agli studenti che non potevano permettersi di comprarne e dicevo loro: «Mangia. Mangia tutto quello che vuoi». Non mi preoccupavo di come guadagnare i soldi: potevo andare dovunque, lavorare a giornata e sfamarmi. Mi piaceva guadagnare e poi usare il denaro per aiutare gli studenti che non ne avevano per pagare la loro retta. Aiutare gli altri e dar loro da mangiare mi riempiva di energia.
Dopo aver regalato tutto il denaro che avevo, lavoravo come fattorino, usando un carretto tirato da una bicicletta. Con quel mezzo andai in ogni zona di Tokyo. Una volta a Ginza, il quartiere dalle luci sfavillanti, stavo trasportando sul mio carretto un palo del telefono, che si rovesciò nel mezzo di un incrocio. Tutti quelli che erano intorno corsero a mettersi in salvo. Grazie a questo tipo di esperienze ancora oggi conosco molto bene Tokyo.
Ero un operaio tra gli operai ed ero amico degli operai. Andavo a lavorare nei cantieri e puzzavo di sudore proprio come loro. Erano i miei fratelli e io non mi preoccupavo del loro odore terribile. Condividevo con loro coperte così sporche che file di pidocchi neri le percorrevano in formazione. Non esitavo a stringere mani incrostate di sporco. Il sudore mischiato alla sporcizia era controbilanciato però da un irresistibile calore umano. Mi colpiva e mi coinvolgeva il loro caldo cuore.
All’inizio lavorai come operaio alle fonderie ed ai cantieri navali Kawasaki. C’erano delle chiatte che venivano usate per trasportare il carbone. Formavamo squadre di tre operai e, lavorando fino all’una di notte, le caricavamo di carbone. Noi Coreani riuscivamo a completare in una notte il lavoro che i Giapponesi avrebbero finito in tre giorni.
In certi luoghi di lavoro c’erano persone che sfruttavano il lavoro degli operai, e spesso si trattava dei loro stessi capisquadra. Tenevano per sé il trenta percento del salario guadagnato dai lavoratori sotto il loro comando. Di fronte a loro gli operai erano impotenti. I capisquadra sfruttavano i più deboli e favorivano i più forti. Mi arrabbiai così tanto con un caposquadra che andai a trovarlo insieme a due amici e pretesi che pagasse agli operai tutto il loro salario: «Se fai lavorare qualcuno – gli dissi – gli devi dare esattamente quanto gli è dovuto». Egli rifiutò, così noi andammo a parlargli un secondo giorno e poi un terzo. Eravamo decisi a tenerlo sotto pressione finché non si fosse arreso. Alla fine gli diedi un calcio e lo feci cadere a terra. Normalmente sono una persona quieta e paziente ma, quando mi arrabbio, riemerge il carattere testardo della mia gioventù.
La fonderia Kawasaki aveva delle vasche utilizzate per conservare l’acido solforico. Gli operai le pulivano facendone defluire il contenuto e calandosi all’interno. Poiché i vapori dell’acido solforico sono estremamente tossici, una persona non poteva trattenersi lì dentro per più di un quarto d’ora. In quelle deplorevoli condizioni di lavoro, gli operai rischiavano la vita per guadagnarsi da mangiare. Il cibo era davvero prezioso.
Avevo sempre fame, ma facevo attenzione a non mangiare mai, neanche un solo pasto, esclusivamente per me stesso. Sentivo che doveva esserci un motivo specifico per mangiare quel determinato pasto. Così, ogni volta che mi sedevo a mangiare, mi domandavo quali fossero le ragioni della mia fame: «Ho lavorato abbastanza? Ho lavorato per me stesso o per uno scopo pubblico?». Mi mettevo davanti alla scodella di riso e dicevo: «Ora ti mangerò in modo da poter assolvere compiti più importanti e più utili per il bene pubblico rispetto a quelli di ieri».
Allora, il riso mi sorrideva in segno di approvazione e il tempo che trascorrevo a consumare il pasto diventava mistico e gioioso. Se non mi sentivo qualificato a parlare in questo modo, saltavo il pasto, non importa quanto fossi affamato. Di conseguenza non erano molti i giorni in cui mangiavo due volte.
Non mi limitavo a due pasti al giorno per mancanza di appetito. In realtà, quando cominciavo a mangiare, non c’era limite alla quantità di cibo che potevo ingerire. Una volta, mangiai undici grandi tazze di spaghetti di soia tutte insieme. Un’altra volta, mangiai sette piatti di una pietanza fatta di riso, pollo e uova fritte. Malgrado il mio appetito, mantenni l’abitudine di non mangiare a pranzo e mi limitai a un massimo di due pasti al giorno, fino a dopo i trent’anni.
La sensazione della fame è una sorta di nostalgia. Conoscevo molto bene la nostalgia data dalla fame, ma reputavo che il sacrificio di un pasto al giorno fosse il minimo che potessi fare per il bene del mondo.
Oltre a questo, evitavo di indossare abiti nuovi e, per quanto facesse freddo, non riscaldavo mai la mia stanza. Quando la temperatura era estremamente rigida, usavo un giornale per coprirmi: mi teneva caldo come una coperta di seta. Ho ben presente il valore che può avere un foglio di giornale.
A volte andavo a vivere per un po’ di tempo in una zona di Shinagawa dove vivevano dei poveri. Dormivo con loro, usando degli stracci come coperte. Nei giorni caldi e soleggiati, toglievo loro i pidocchi dai capelli e mangiavamo insieme. C’erano tante prostitute nelle strade del quartiere. Le ascoltavo mentre mi raccontavano le loro storie. Divenni il loro migliore amico, ma non bevvi mai neanche una goccia di liquore: alcuni dicono che, per parlare sinceramente, bisogna essere un po’ ubriachi, ma si tratta solo di un pretesto. Quando quelle donne si rendevano conto che la mia simpatia per loro era sincera, anche se non avevo affatto bevuto, mi aprivano il loro cuore e mi parlavano dei loro affanni.
Ho fatto tanti diversi lavori durante il periodo dei miei studi in Giappone. Ho fatto le pulizie in un palazzo di uffici. Ho scritto lettere per gli analfabeti. Ho lavorato in tanti posti diversi e sono stato un caposquadra. Ho predetto il destino. Quando dovevo fare soldi alla svelta, scrivevo calligrafie e le vendevo. Tuttavia, non sono mai rimasto indietro con gli studi. Pensavo che tutte queste cose dovessero essere parte del mio addestramento. Feci ogni tipo di lavoro e incontrai ogni tipo di persona. Nel frattempo, imparavo tante cose sulla gente. Poiché ho avuto queste esperienze, ora mi basta dare un’occhiata a qualcuno per farmi un’idea di cosa faccia per vivere e se sia o meno una brava persona. Non ho bisogno di valutare nella mia testa tanti pensieri, perché il mio corpo mi dà immediatamente la risposta.
Credo tuttora che per sviluppare un buon carattere sia necessario sperimentare tante difficoltà prima di compiere i trent’anni. La gente deve scendere nell’agonia della disperazione, toccare il fondo dell’esistenza umana e constatare cosa si provi in quelle condizioni. Le persone devono scoprire le nuove possibilità che possono emergere nel mezzo dell’inferno. Solo risalendo dagli abissi della disperazione, e rideterminandoci con motivazioni più grandi, possiamo rinascere come pionieri di un nuovo futuro.
Non dobbiamo guardare in una sola direzione. Dobbiamo osservare sia quelli che sono in una posizione più elevata della nostra, sia quelli che sono sotto di noi. Dobbiamo saper guardare a est, ovest, sud e nord.
La possibilità di condurre una vita di successo dipende da quanto sono acuti i nostri occhi della mente. Per vedere bene con gli occhi della mente, dobbiamo vivere tante diverse esperienze e conservarne dentro di noi il ricordo. Anche nelle situazioni più difficili dobbiamo mantenerci calmi, manifestare agli altri il nostro calore, fare conto su noi stessi e adattarci in fretta a qualsiasi circostanza.
Una persona di buon carattere deve essere abituata a salire fino a una posizione prestigiosa e poi, rapidamente, precipitare in una posizione infima. Molti temono di cadere dalla loro posizione elevata e fanno qualsiasi cosa per mantenerla. Tuttavia, l’acqua che non scorre diventa putrida. Chi giunge fino ad occupare una posizione elevata deve essere in grado di ridiscendere e attendere che il suo momento ritorni. Quando si presenterà l’occasione giusta, potrà elevarsi ad uno stato ancora più elevato del precedente. Questo è il tipo di persona che può diventare davvero grande ed essere ammirato da tante persone, e diventare così un grande leader. Queste sono le esperienze che una persona deve maturare prima dei trent’anni.
Oggi dico ai giovani di provare davvero tutto quello che è possibile al mondo. I giovani devono sperimentare, direttamente o indirettamente, tutte le opportunità che il mondo offre loro, come se divorassero un’enciclopedia. Solo così possono formarsi una loro identità.
La consapevolezza di sé è la chiara natura soggettiva di ciascun uomo. Chi ha il coraggio di dire: «Posso viaggiare per tutto il Paese, e non incontrerò mai nessuno capace di sconfiggermi», sarà pronto ad affrontare qualsiasi impegno, con la fiducia che potrà assolverlo con successo.
Chi vive in questo modo sarà vittorioso. Il successo sarà assicurato. Questa è la conclusione cui sono giunto quando vivevo come un mendicante a Tokyo. A Tokyo ho mangiato e dormito insieme con i manovali, ho condiviso il supplizio della fame con i mendicanti, ho conosciuto la durezza della vita e mi sono laureato nella filosofia della sofferenza. Solo così sono stato in grado di comprendere la volontà di Dio, nel Suo lavoro per portare la salvezza all’umanità. È importante diventare un «re della sofferenza» prima dei trent’anni d’età. La strada per arrivare alla gloria del Regno dei Cieli è diventare un tale «re», una persona capace di sopportare qualsiasi sofferenza.
(da La Mia Vita per la Pace, Sun Myung Moon, 2010)